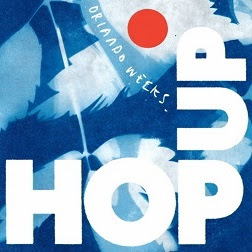La pianista e compositrice islandese Eydis Evensen possiede un talento naturale per creare melodie assolutamente meravigliose, che si gonfiano potenti, per infrangersi come onde sulla battigia, e poi, di nuovo, tornare a ricompattarsi nel gorgo schiumoso della risacca. Viene spontaneo usare questa immagine naturista per raccontare Bylur (in islandese significa: tempesta di neve), un vero e proprio viaggio, da fare a occhi chiusi, attraverso gli elementi naturali, in particolare l'acqua e l'aria. E proprio come onde, le tredici tracce che compongono la scaletta dell’album, fluiscono nella nostra immaginazione, offrendoci uno sguardo, intenso e poetico, sulla vita in Islanda, iniziando la narrazione dal piccolo paesino in cui è cresciuta Evensen.
Bylur è un album avvolto nella nostalgia dei ricordi, estremamente romantico e dotato di un lirismo marcatamente femminile. Il modo in cui Eydis suona il piano, con quel tocco così ingenuamente appassionato e quel ritmo costante, crea un moto perpetuo in cui ogni singola traccia assume le vivide sembianze di un flusso d'acqua costante. Un’onda, come scrivevamo in apertura. Non ha bisogno di artifici, Evensen, non gioca a stupire, non cerca il colpo di scena, lascia semplicemente che la musica l’attraversi, dal cuore alle dita, per evocare, giocando con le note e i ricordi.
Un disco post classico, nella sua accezione più nobile, che attorno alla centralità del pianoforte, si poggia, in delicato equilibrio, sui ricami degli archi, avvolgenti e spudoratamente catchy, o sull’uso parco e discreto degli ottoni e dei sintetizzatori. Ne escono brani magnifici, forse un po' prevedibili, come "Deep Under", "Northern Sky" e "Wandering I & II", che, tuttavia, sanno affascinare, seducendo con le armi del languore contemplativo e dello struggimento dell’anima.
E’ un volo sopra la terra d’Islanda, su quei magnifici paesaggi, selvaggi come lo può essere un’anima tormentata, eppure estremamente attrattivi, come lo è la bellezza, che non ha bisogno di fingimenti per risplendere alla luce del sole. Evensen può dispiegare le ali e spiccare il volo, anche quando veste abiti francescani, come avviene nel solo di pianoforte di "Nturdogg", traboccante di emozione e passione, o quando azzarda una ballata decisamente pop in "Midnight Moon", unica traccia cantata, con ospite GDRN, la cui voce, bassa e morbida, evoca un paesaggio quasi lunare.
E mentre la title track si appresta chiudere il disco, è ormai chiaro che questa ragazza ti ha completamente irretito. Perché anche se è vero che questo disco non riesce ad affrancarsi da una certa iconografia tradizionale di quella che chiamiamo classica moderna, è capace, comunque, di toccare le corde dell’anima, grazie una stile cinematografico che trasuda cuore e calore e che, soprattutto, riesce a trasportare l’ascoltatore in una dimensione parallela. Basta abbandonarsi al flusso delle note, immergersi nella natura e inizia a sognare.
VOTO: 7
Blackswan, lunedì 31/01/2022