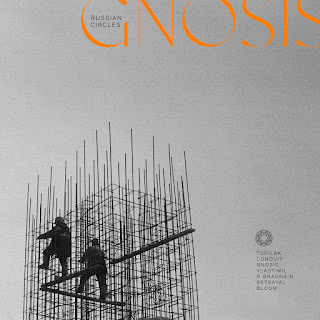Nel bel mezzo della cartina dell'Oklahoma, c'è un crocicchio di case chiamato Okemah, in cui vivono tremila anime, un terzo delle quali sono nativi americani. Appena poco più grande di un buco di culo, insomma. E nonostante ciò, Okemah è un luogo ricco di storia musicale, visto che ha dato i natali al grande Woody Guthrie e a un'altra Guthrie, Gwen, figura di riferimento del r'n'b anni '80. Sarà l'aria particolarmente buona, ma da queste parti nasce anche John Fullbright, classe 1986 e, fin dall’inizio della sua carriera, considerato giovane promessa del cantautorato a stelle e strisce.
Un artista così dotato che, infatti, con il suo primo lavoro in studio, From The Ground Up (2012), ottiene subito successo commerciale, apprezzamento della critica e una nomination ai Grammy Awards per il miglior album di Americana. Due anni di attività concertistica ma anche di studi, hanno portato il songwriter dell’Oklahoma a una completa maturazione artistica e a un nuovo disco, Songs (2014), altrettanto bello, composto da dodici canzoni, per cinquanta minuti di durata, in cui è la ballata intimista e confessionale, e una scrittura sincera e appassionata, a far la parte del leone.
Oggi, a distanza di otto anni (un’eternità rispetto alle tempistiche dell’odierno mercato discografico) John Fullbright esce con un nuovo album, intitolato The Liar, ed è chiaro che il trentaquattrenne musicista americano ha fatto buon uso di tutto il tempo trascorso. Ha ingaggiato una nuova band per farsi accompagnare in studio, ha ampliato il proprio spettro musicale e ha consolidato, arricchendolo, il proprio stile. Uno scostamento dalle origini, che potrebbe in qualche modo spaventare i fan della prima ora, quelli che si aspettano la semplice intensità di un uomo chino sul suo pianoforte. Quel tipo di songwriting non è svanito del tutto, e infatti The Liar inizia con "Bearden 1645", un brano che palesa quale sia la comfort zone di Fullbright e che evoca un mood alla Billy Joel, anche se poi la canzone si arricchisce con un bell’assolo di slide.
C’è, però, un maggiore eclettismo in questo nuovo lavoro, che pur mantenendo una famigliarità emotiva, esibisce un’espressività più varia: in "Safe To Say" l’organo si sostituisce al piano per un brano dagli accenti fortemente gospel, la title track è una ballata che si sviluppa su coordinate country soul, "Where We Belong" è un classicissimo country accarezzato dal violino, mentre l’autoironica "Social Skills" è una filastrocca rock di due minuti, dritta e diretta, e senza fronzoli. Il pianoforte resta, ovviamente, il fulcro della musica di Fullbright, e anche se lo strumento viene avvolto spesso da arrangiamenti più corposi, le ballate spezza cuore, che sono il fiore all’occhiello del musicista dell’Oklahoma, non mancano ("Stars" e "Lucky" sono da brividi).
Registrato nello studio della fattoria di Steve e Charlene Ripley nel nord-est dell'Oklahoma, The Liar si avvale della presenza di alcuni dei migliori musicisti dello stato, la maggior parte dei quali ha già lavorato con Fullbright, tra cui Jesse Aycock, Aaron Boehler, Paul Wilkes, Stephen Lee e Paddy Ryan. Sono stati impiegati solo quattro giorni per registrare le dodici canzoni, ma nonostante le tempistiche compresse, il disco non è certo un parto frettoloso, anzi replica la brillantezza di Songs e From The Ground Up, offrendo una scaletta più ricca e composita, che non manca di toccare le corde del cuore grazie al consueto surplus di emotività.
Otto anni sono davvero una lunghissima distanza fra un disco e l’altro, ma queste dodici canzoni di ottima fattura, sono riuscite ad azzerarla. E, tutto sommato, è valsa la pena aspettare.
VOTO: 7,5
Blackswan, lunedì 31/10/2022